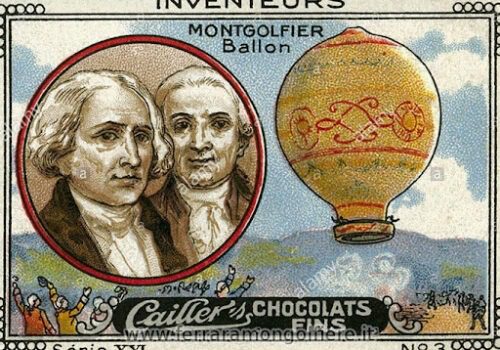L’acacia
Aspettava il furgone dalla mattina di buon’ora. I cari di casa l’avevano lasciata sola: chi al posto di lavoro, chi a scuola. Era una di quelle giornate in cui il sangue formicola veloce nelle vene e ti solletica ad agire. In casa c’erano tante cose da sbrigare e lei voleva essere pronta per quando il furgone sarebbe arrivato.
Di buon’ora s’era destata ma c’era sempre qualcosa o qualcuno che la costringeva a ritornare alla finestra che incorniciava i lunghi rami spogli dell’acacia. Il cielo, a pezzetti, sembrava rannuvolato e il praticello era cosparso dai ventagli che cominciavano ad accartocciarsi.
Ad un tratto le sembrò di non vedere bene, da poco portava le lenti che non amava perché la rendevano più vecchia e saggia. Una giovane donna in una succinta tunichetta di fine estate, distesa sulla sedia a sdraio, prendeva il sole e i rami dell’acacia le striavano d’ombra il viso, il ventre appena arrotondato e le gambe. Avrebbe voluto avvertirla, dirle di spostarsi un po’ più in là, fuori del cono d’ombra dell’albero. Ma il sibilo della caffettiera la fece allontanare: c’era da sbrigare tutto in cucina e lei voleva essere pronta per quando il furgone sarebbe arrivato.
S’affrettò verso la finestra: il silenzio della grande casa non era così profondo da non farle sentire il cicaleccio sorridente delle persone assiepate sotto l’albero, in posa per la fotografia. Dopo si muovevano sull’erba, attorno al tronco, a tempo di valzer, scambiando le guance e le mani per i saluti, accarezzando la testa dei più giovani, sollevando di tanto in tanto il volto verso l’alto dove le infiorescenze dell’acacia battevano appena l’aria con il loro odore.
Lo squillo del telefono la chiamò, era sua madre, non voleva stare troppo con la cornetta in mano perché in casa c’erano tante cose da sbrigare e lei voleva essere pronta per quando il furgone sarebbe arrivato. Con calma salì le scale gettando occhiate distratte al disordine dello studio, per passare poi nelle stanze da letto a riassettare.
Dalla sottile e lunga finestra del bagno le giunsero sordi rintocchi. Riuscendo a malapena a vedere le cime più alte dell’albero che precipitavano giù pensò che suo padre non aveva scelto un bel momento per potare l’acacia. Faceva freddo, pareva che da lì a breve dovesse nevicare e si sa che i rami potati con il gelo non ce la fanno a promettere fiori in primavera. La rallegrava il pensiero dei ciocchi che avrebbe gettato a bruciare nel caminetto per arrostire le castagne. Sprizzavano buone scintille ed avevano un odore buono.
Il cane, che la seguiva dappertutto, reclamò con un’abbaiata la razione mattutina, la gattina nera e bianca la guardava con occhi sbalorditi: corsero in cucina e lei con loro, ma doveva fare presto perché voleva essere pronta per quando il furgone sarebbe arrivato. Da sola, nella grande casa, non era abituata a commentare a voce alta ciò che faceva; a farlo bastava la sua amica che un po’ fuori di testa lo era. Lei preferiva pensare alle cose, catalogarle sistemandole in ordine e raziocinio nella testa.
L’indispettì tuttavia il fatto che piovesse e che avesse steso da poco la biancheria all’aperto. Il ciglio dell’altalena appesa all’acacia s’era spento grazie alla pioggia che aveva ingrossato la treccia della corda; Nicolò avrebbe potuto dondolarsi ancora senza che qualcuno lo sentisse e gli raccomandasse di andare a studiare invece di perdere tempo a trastullarsi. Quella mattina lei non era in vena di predicozzi. Vedere le gambe grassocce e nude del bambino che andavano in su e in giù la metteva in allegria. Un pensiero le guastò il buonumore: da un po’ di tempo era costretta a cancellare orribili macchie viscide che ricoprivano il vialetto, le rose, il pavimento di casa. Dalla chioma dell’acacia scendeva fitta un’acquerugiola iridescente che s’appiccicava dappertutto, qualcuno aveva raccontato che tutte le acacie erano ammalate e che forse era colpa del terrorismo internazionale. Non s’era rassegnata a perderla, aveva lottato fino in fondo davanti a chi le consigliava di abbattere il gigante ormai ammalato. Piantata un anno o forse prima che la casa fosse abitata, da esile e sparuto alberello era diventata una pianta gigantesca, con un tronco possente e una chioma talmente folta e vasta da far da cappello al praticello, da cancellare il grigio brutto della casa, da assorbire perfino le trecce delle corde dell’altalena, come fossero state vene di linfa per la sua corteccia. Aveva qualcosa d’umano quella pianta: il colore delle infiorescenze ricordava le guance di Giulia che giocava fra gli spruzzi dell’acqua della sua piscinetta di gomma; i rami con le foglie lunghe e sottili erano mani aperte per gli amici che volessero entrare; il tronco sembrava il braccio di un gigante con l’ombrello a difendere dal sole le rose, i ciuffi di giacinti che crescevano qua e là nel praticello, i giocattoli abbandonati nell’erba. Si era rivolta ad esperti di floricoltura, abili manipolatori di veleni, pesticidi, antiparassitari. La risposta era sempre stata la stessa: abbattere, abbattere, abbattere. L’ultima potatura autunnale aveva lasciato un pietoso pugno di dita monche. Invano. Verso la fine dell’estate era giunta la decisione: al suo posto sarebbe cresciuta una magnolia giapponese.
Il trillo della sveglia la sorprende come il solito. E’ sola nel letto, lui è già uscito. Dalla casa non provengono rumori, gli altri se ne sono andati. Resta a fissare le lame di luce che filtrano dalla tapparella. Si sente insonnolita e un po’ angosciata. No, angoscia per lei è una parola seria, un leggero fastidio. Getta un’occhiata alle lancette: ha dormito sodo, tanto da non avvertire lui che russava a tal punto da costringerla ad emigrare verso il letto della mansarda.
Ripensa al sogno della notte.
Ricorda vagamente di aver aspettato, aspettato, aspettato. Mentre scende le scale il campanello suona.
Si sente pronta.
Davanti al cancello un grosso furgone sta aspettando.

(Immagine tratta dal web)