Codardia
Non capisco che cosa mi spinse ad uscire da casa quella sera d’agosto, saltare in sella alla bicicletta parcheggiata in giardino e pedalare via. C’era il caldo opprimente di un’estate capricciosa, altalena di giorni in cui il sole impietriva i sassi e scoppi di temporali con arcobaleni improvvisi ed iridescenti. Mio marito, lontano per turno di lavoro, m’aveva lasciata sola davanti alla televisione a sciropparmi un’insulsa trasmissione. Non era tardi, circolava qualche vettura, i marciapiedi erano però deserti, di biciclette neanche a parlarne. Non scelsi di addentrarmi nel parco, un’incombente macchia nera, silenziosa, lambita dagli aloni dei lampioni che costeggiano i viali. Mi tenni sulla ciclabile che corre parallela alla strada. L’aria s’era fatta fresca e pedalavo lentamente per gustarmela e non pensare a niente.
Alla svolta della strada la vidi per terra, un mucchietto nero sul marciapiede. Mi avvicinai. Era vestita di scuro, si lamentava con una vocetta flebile, un rivolo di sangue le usciva dalla testa. Teneva gli occhi ostinatamente chiusi alle mie domande insistenti, inutili.
Attorno non c’era anima viva: quel tratto di strada non presenta che orti e pioppeti solitari, dalle case lontane si sentivano latrati di cane nell’oscurità. Ricordai che in borsa il cellulare era acceso e avrei potuto chiamare il 118. Arrivarono dopo dieci minuti. Interminabili senza che un’auto passasse di là e senza che la donna si decidesse a rispondere.
– E’ una sua parente?
– A che ora l’ha trovata?
– La ricoveriamo per accertamenti …
L’infermiere piccolo, biondo, molto gentile mi parlava. L’altro, alto e robusto, la caricava nell’ambulanza. La luce viola lampeggiò sul mio volto perplesso quando quello affermò:
– Se crede può accompagnarla in ospedale, date le circostanze!
Mi ritrovai seduta accanto alla sconosciuta che non si lamentava più, aveva aperto gli occhi e mi fissava sorridendo. Non poteva avere più di settant’anni, di sicuro era più giovane di mia madre che veleggiava verso gli ottanta. Un volto paffuto, fresco, i capelli argentei in una bella messa in piega anni sessanta, gli occhi grigi, un po’ sbiaditi.
– Non ha documenti … – osservò l’infermiere robusto.
– Sarà caduta … – azzardai a disagio e improvvisamente cercai di ricordare se avevo chiuso il lucchetto della bicicletta. Non l’avrei ritrovata fino al ritorno, avevo sentito che in quei giorni razziavano bici a più non posso, la mia era un ferro arrugginito e cigolante, ma il pensiero di perderla m’indispettì.
“Vuoi vedere che per colpa di questa qui me la fregano! – e distolsi lo sguardo dal suo.
Avrei voluto essere a casa mia.
Al Pronto Soccorso ci parcheggiarono in un corridoio bianco, lungo e stretto come un budello di miniera. Io in piedi, lei sulla barella e continuò il nostro silenzio: avevo capito che la donna non mi avrebbe mai risposto, lei era perduta dentro chissà quale incantamento. Il rivolo di sangue s’era rappreso e le fioriva sulla fronte una grossa macchia violacea. Le ginocchia ossute erano graffiate e una sdrucitura sulla manica del vestito. Si lamentava di tanto in tanto, roteava gli occhi, li chiudeva, li riapriva, tornava a fissarmi e a sorridermi.
Distolsi lo sguardo impaziente, ma perché ci mettevano tanto a riceverci! Volevo andarmene, tornare a casa e al diavolo la bici incustodita nel parco. Finalmente un medico ci fece entrare.
– Non la conosco, non c’era nessuno …
Il medico la visitò: nell’auscultare il cuore, intravidi un medaglione, uno di quelli che contengono foto.
Uno di simile l’avevo regalato alla mamma poco dopo la morte di mio padre: l’istantanea li ritraeva giovani fidanzati irriconoscibili in bianco e nero. Mia madre lo portava al collo come una reliquia, non se ne separava nemmeno per fare la doccia, col risultato che i colori s’erano sbiaditi e confusi. Pensai a lei e m’innervosii: a distanza di tre anni dalla scomparsa di mio padre il copione era sempre lo stesso. Ogni volta che mi vedeva si metteva a piangere, io le dicevo che era diventata una vecchia piagnucolona, forse sarebbe bastata una carezza sulla mano, ma era diventato difficile abbracciarla o baciarla, ne sentivo l’odore di capelli mal lavati, di pelle trascurata e vecchia, di respiro che sapeva di denti ingialliti ed incrinati. Mi prendeva la voglia di andarmene; eppure nelle fotografie di un tempo il suo sorriso era fresco, l’aspetto curato, gradevole, chissà quanti baci le avevo dato.
L’infermiere propose di guardare nel medaglione. C’era la foto di un bambino. La donna afferrò le mani che avevano aperto il gioiello.
– Carlo … – le uscì come un soffio.
– Chi è Carlo? Signora, ci aiuti – disse il medico. C’era molta pazienza nella sua voce.
– Ci dica il suo nome, così possiamo chiamare qualcuno della sua famiglia …
Nell’ambulatorio non era accesa l’aria condizionata e le finestre erano sigillate. Sentii una grande stanchezza, mi pizzicavano gli occhi sotto le luci bianche, l’aria sapeva di disinfettante, del mio sudore, di malattia.
Sbirciai l’orologio, sarei ritornata volentieri a sciropparmi l’insulsa trasmissione televisiva piuttosto che star là, al capezzale di una sconosciuta, caduta sulla mia strada, in una sera d’agosto.
Quella volta che papà aveva subito l’operazione, non m’era garbato molto andare a trovarlo in ospedale. Mamma me ne aveva fatto una colpa. Io non ero riuscita a non spiegarle nulla. Ricordo un vago senso di vergogna: non volevo pensare al corpo martoriato di papà e non avevo trovato le parole giuste.
– Si tratta di una caduta accidentale – osservò il medico – non ci sono lesioni serie … propongo un esame radiologico della testa.
– Ma … dottore … – balbettai – non sono una parente … non so … cosa devo fare?
– Finché non rintracceremo qualcuno per stabilire chi è … non possiamo far nulla! In ogni caso lei è libera di andarsene – concluse indicando la porta – lei ha già fatto tanto!
Guardai la donna, il suo sorriso ineffabile.
– Mi faccia avvertire mio marito! – esclamai pescando dalla borsa il cellulare. La sua voce ansiosa e gentile mi ascoltò; m’incoraggiò a rimanere, anzi mi avrebbe raggiunta in ospedale.
Intanto ci parcheggiarono in un altro corridoio: camici bianchi e verdi, passaggio di barelle, ticchettio di zoccoli di gomma, volti preoccupati, sguardi stanchi, cigolio di porte aperte e chiuse, lamenti lontani.
Pensai che di notte il Pronto Soccorso pullula di vita come una piazza in pieno giorno. C’è solo la luce artificiale e l’insopportabile odore della malattia a ricordare dove ci si trova c’è sofferenza e morte.
All’improvviso mi sentii toccare: la mano della sconosciuta era sulla mia. Le feci una carezza.
– Non si preoccupi signora, arriveranno i suoi e la riporteranno a casa …
In quel momento si spalancarono le porte, entrarono un uomo e una donna accompagnati da un agente di polizia.
L’agente mi rivolse delle domande, la donna si chinò sull’anziana e con voce dolce la chiamò baciandole la fronte.
– E’ uscita di nascosto … non l’aveva mai fatto…
– Per fortuna è passata la signora in bicicletta – disse l’agente.
– Siamo usciti a cercarla ma il parco è talmente grande … poi qualcuno ci ha parlato della sirena dell’ambulanza e così abbiamo capito!
La donna mi prese le mani e mi ringraziò.
Uscii.
Mio marito mi venne incontro lungo la rampa d’accesso al Pronto Soccorso. Mi cinse le spalle.
– Domani vado da mamma – dissi e pensai:
“Non devo scordare di darle un bacio sulla fronte …



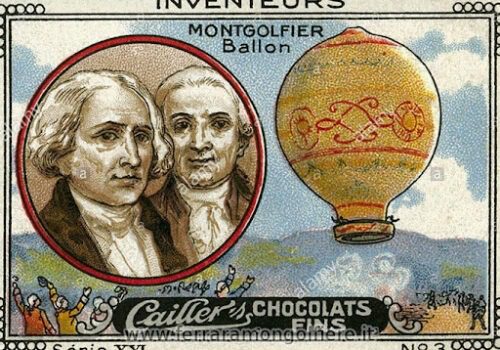


Bello e commuovente mi ricorda tanto la mamma
Bella mi e piaciuta