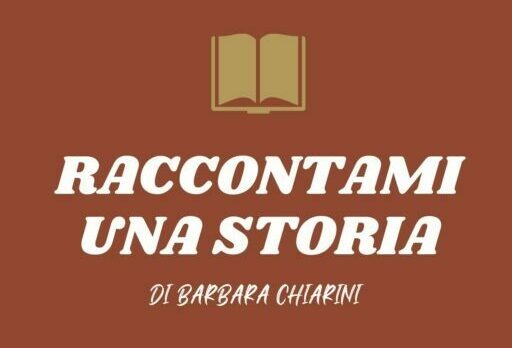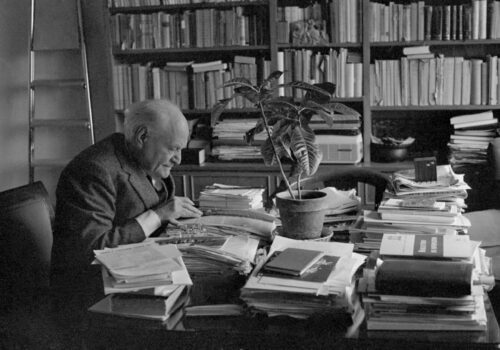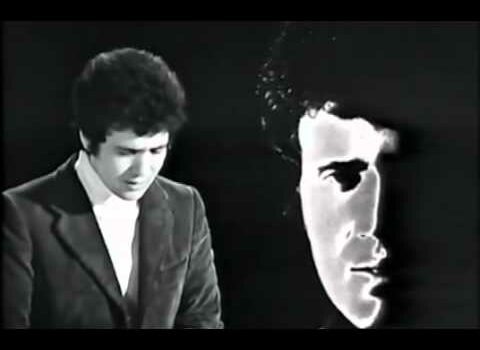Frankenstein, il moderno Prometeo
«Fu in una tetra notte di novembre che vidi il compimento delle mie fatiche. Con un’ansia simile all’angoscia radunai gli strumenti con i quali avrei trasmesso la scintilla della vita alla cosa inanimata che giaceva ai miei piedi.»
Inizia con queste parole il romanzo scritto più di duecento anni fa da una giovane inglese di appena 19 anni (1816).
Pubblicato in forma anonima due anni dopo, l’11 marzo 1818, sarebbe diventato uno dei romanzi più conosciuti di sempre. La giovane in questione si chiamava Mary Wollstonecraft Godwin (1797-1851), il libro era Frankenstein o il Prometeo moderno”.
Mary era moglie del poeta romantico Percy Bysshe Shelley (1792-1822), delle cui opere fu anche curatrice. Il padre di Mary, William Godwin (1756-1836), era un importante filosofo politico e la madre, Mary Wollstonecraft (1759-1797)che morì nel darla alla luce, una delle prime pensatrici femministe inglesi.

Frankenstein vide dunque una sua prima pubblicazione nel 1818 (con una prefazione del marito e una dedica al padre), ma nel 1823 uscì in Francia una seconda edizione del romanzo, questa volta con il nome dell’autrice. Nel 1831, sempre sull’onda del successo del romanzo, ne fu stampata una terza che, per l’occasione ,fu fortemente rivista dall’autrice.
Forse non tutti conoscono la curiosa origine del romanzo , che nacque da una competizione letteraria tra amici. Durante l’ estate del 1816, Mary e Percy soggiornano in una villa sul lago di Ginevra con John Polidori (1795-1821), ospiti di Lord Byron (1788-1824), a quel tempo amante della sorellastra di Mary ,
Il tempo piovoso (fu definito l’anno senza estate) confinava spesso i dimoranti nella loro residenza di Villa Diodati: per occupare il tempo libero si leggevano storie tedesche di fantasmi, tradotte in francese e raccolte nell’antologia Fantasmagoriana. Byron propose allora di comporre loro stessi una storia di fantasmi: tutti cominciarono a scrivere, ma Mary non ebbe subito l’ispirazione.
Intanto le lunghe conversazioni degli uomini vertevano sulla natura dei princìpi della vita, sul galvanismo, sulla possibilità di assemblare una creatura e infondere in essa la vita. Tali pensieri scatenarono l’immaginazione di Mary e portarono all’incubo che è all’origine del grande mito gotico: uno studente che si inginocchia di fianco alla creatura che ha assemblato; creatura che, grazie a una qualche forza, comincia a mostrare segni di vita.
Mary inizia dunque il racconto decisa a ricreare quel terrore che lei stessa ha provato nell’incubo che fu la sua creazione: protagonista il medico Victor Frankenstein il quale, assemblando pezzi di cadavere raccolti negli obitori, costruisce una creatura deforme cui dà vita attraverso una scarica elettrica. Il mostro sfugge al suo controllo, perpetrando omicidi e violenze in tutta Europa, fino al tragico epilogo che accade al Polo Nord.
Una volta tornata in Inghilterra, incoraggiata dal marito, Mary sviluppò a pieno la storia. Da questo strano gioco pensate che nasceranno non solo il mito di Frankenstein ma anche Il vampiro (1819) di Polidori, romanzo breve che fonda tutte le storie sui vampiri, fino al Dracula (1897) di Bram Stoker (1847-1912), dando in tal modo vita ad un nuovo genere di romanzo definito dalla critica moderna gotico – horror – fantasy
A rendere Frankenstein così attuale – come dimostrano i numerosi adattamenti cinematografici succedutisi nel tempo – sono prima di tutto le tematiche trattate. Tra le pagine si spazia infatti dal rapporto tra bene e male, si oscilla tra la vita e la morte, fino a analizzare i dubbi che scaturiscono dal desiderio di conoscenza e i limiti che ne conseguono.

Mary aveva sperimentato in prima persona il binomio vita/morte di cui poi parlò nel suo libro. La madre infatti era deceduta pochi giorni dopo averle dato la luce; nel 1816 la stessa Mary aveva perduto la bambina avuta con Percy, nata prematura.
Oltre che delle tragiche esperienze personali l’opera risentì senz’altro altro del galvanismo (che sostiene la presenza di un’elettricità intrinseca negli esseri viventi) e delle dottrine filosofico-scientifiche dell’epoca, incentrate sulla natura dell’origine della vita e sulla possibilità di ingenerarla in organismi inanimati.
La figura del mostro, espressione della paura associata ad un acerbo concetto di sviluppo tecnologico, contribuì alla diffusione del romanzo e a renderlo immortale.
Frankenstein è uno dei miti della letteratura proprio perché affonda le sue radici nelle paure umane. La creatura è l’esempio del sublime, del diverso che, in quanto tale, causa terrore.
Portato sul grande schermo per la prima volta nel 1910, come cortometraggio prodotto da Edison Studios a New York, il romanzo ha ispirato anche innumerevoli altre trasposizioni cinematografiche: la più recente è del 2015, con Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein del regista Paul McGuigan.