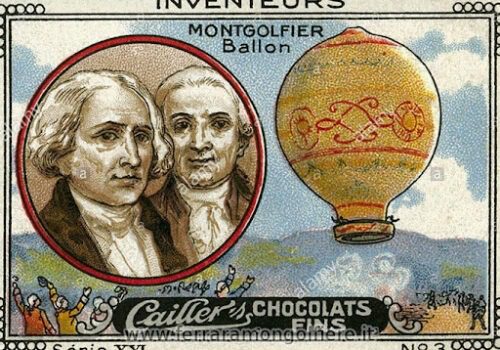La signora Muttone – Prima Parte
Il giorno in cui portarono via la signorina Sbrilli, Rosa Muttone stava al telefono con la figlia. Il tramestio che scoppiò nel bel mezzo del caseggiato la costrinse a troncare la conversazione ed affacciarsi sul pianerottolo. Giusto in tempo per vedere arrancare sulle scale il signor Giacomo carico delle sporte della spesa. Gli altri usci cigolarono. Rimase a naso in su con gli occhi incollati alla tromba delle scale dove l’eco delle grida della signorina Sbrilli si amplificava disumana, finché non scesero due energumeni in camice bianco con la povera donna che sfarfallava fra loro in camicia da notte.
-Ma ha visto che occhi spiritati? – le chiese il signor Giacomo. Sentì gli occhi umidi. Le bastava poco per inzuppare il fazzoletto. Chi non la conosceva poteva pensare che soltanto una sciocca sentimentale si commuovesse per film d’amore e canzoni di bambini, ai matrimoni, battesimi e funerali. Era molto emotiva e sensibile e credeva nel genere umano. Figurarsi se non si sarebbe sciolta in lacrime nel vedere la signorina Sbrilli trascinata via dai due infermieri come un sacco di stracci da buttare. Le voci si rincorsero nella tromba delle scale affollata come non mai.
-Chi l’avrebbe detto!
-L’altra sorella è morta qualche mese fa ed ora tocca alla signorina Lidia …
-Ho sentito l’ambulanza e c’era anche uno dei servizi sociali …
-Da quando l’ultima badante, quella russa, se n’è andata …
A queste parole il signor Giacomo si eclissò con la scusa che il telefono stava squillando. La signora Muttone s’intrattenne sul pianerottolo guardando verso il fondo delle scale finché balenarono il bianco dei camici ed il rosa della camicia da notte. Poi allo scatto del portone d’ingresso che si richiudeva, decise di rientrare in casa. Si ricompose il silenzio nel caseggiato. Si fece triste e pensò a quando risuonava delle voci dei bambini, delle risate dei giovani, dei rumori di chi, presto o tardi, andava e tornava dal lavoro: ticchettio di scarpe, tonfi di scarponi pesanti, acqua di rubinetto, canzonette, rotolio e rimbalzi di biglie e palloni. Ora che il caseggiato era abitato solo da coppie o persone sole, comunque anziani, c’era più tranquillità. I signori Muttone erano stati i primi ad occupare l’appartamento, poi era arrivata la signorina Lidia Sbrilli e via via tutti gli altri. Provenivano dall’Abruzzo, terra di cardilli, fior e messi d’or, in seguito al trasferimento del maresciallo Muttone, già provvisti di una nidiata di figli, che col passar degli anni, si fece cospicua. Ne avevano sette, di tutte le età, sparsi per mezza Italia, il più grande, sulle orme del padre, era tenente dei carabinieri a Firenze, l’ultima aspettava maggio per renderli nonni. Per la settima volta. Se qualcuno avesse chiesto alla signora Muttone a quale animale pensava di assomigliare, avrebbe risposto ad una coniglia. Aveva figliato per tutta una vita come altre donne sfornano torte e non tutte le ciambelle erano uscite col buco. Tra vivi, morti ed aborti ne avrebbe contati ben diciassette, prima che un medico, preoccupato per lo stato di salute del suo ventre, non le avesse consigliato di tappare definitivamente le tube di Falloppio. Che a dirla così sembrava impressionante e rozzo, ma in verità procurò a Rosa Muttone una vera e propria via di scampo. D’altronde in vita sua non c’era stato posto per attività diverse. Rosa era cresciuta in una famiglia povera e numerosa, passando direttamente dalle mani di un padre autoritario a quelle del maresciallo, transitando per pochi anni in quelle delle monache della scuola che le risparmiò l’onta di essere analfabeta come gran parte della sua famiglia. Il maresciallo era uomo prestante, di tempra energica e volitiva. Gli si abbandonò come creta da modellare e lui la plasmò ad immagine e somiglianza dell’ideale di donna che amava. Rosa era rotonda e formosa, ricca di curve e dossi, soffice e spumosa. Non una ruga le increspava il sorriso, non un filo d’argento tra i capelli; soltanto le mani rivelavano fatica ed il ventre sfiancato. Rassettava, cucinava, lavava, figliava quasi ogni nove mesi, preparava le pantofole calde per il marito senza mai che la sfiorasse l’idea che alla vita si potesse chiedere altro. C’era stato un periodo in cui, subito dopo la licenza elementare, aveva lavorato come rimagliatrice di calze, ma era durato poco, perché il padre l’aveva voluta a casa ad imparare l’arte della cucina e l’alfabeto dell’ubbidienza. Di quella breve parentesi le restava il ricordo di alcune ragazze del paese.
-Chissà che fine fece Antonietta? E Assunta emigrata in Brasile?
Si sentiva pizzicare dalla nostalgia se ci pensava e così per i fratelli e sorelle lasciati laggiù. Li sentiva via telefono o a mezzo lettera. Finché i bambini furono piccoli erano consentite una o due scappate all’anno al paese suo, in occasione del Natale o della Pasqua. Troppo poco per ritrovare gli odori, i colori della terra e del cielo, il sapore ed il calore della gente. Il maresciallo sembrava non provare la nostalgia della consorte: era soddisfatto del lavoro che svolgeva ed apprezzava la gente del Nord.
-Qui sono efficienti, pratici, sbrigativi.
Rosa li trovava un po’ freddi e distaccati questi nordici, parchi di parole e sorrisi. Anche il clima le era ostile. Rosa non era nata nella nebbia, non ne capiva la bellezza. Adorava il sole che al Nord è pallido e schivo. Non le era più capitato di aspirare il buon odore del bucato fresco perché nell’aria si confondevano i miasmi delle polveri sottili e dell’ossido di carbonio. Perfino il verde delle piante era diverso: cresceva polveroso e stento nei vasi di coccio del balcone. Le sembrava che le pietanze avessero sapori e profumi ignoti; mancavano di sapidità e succulenza, perciò si faceva spedire dal paese damigiane di olio, quello buono, spicchi di pecorino, tranci di ventricina, ortaggi che provvedeva a mettere sott’olio o sott’aceto, secondo la ricetta che nonna e mamma le avevano insegnato. Da un cugino mugnaio si faceva mandare la farina per la pasta e i dolci. Era una cuoca eccellente. Nel caseggiato tutti lo sapevano per via degli effluvi di intingoli e soffritti che aleggiavano davanti all’uscio, nelle scale ed al suo passaggio. Ognuno aveva assaggiato le sue specialità: una fetta di parrozzo alla signorina Ghitta, un cartoccio di fiadoni alla giovane coppia dell’ultimo piano, la pasta coi piselli per il signor Giacomo, le bruschette all’aglio e peperoncino per il portinaio. Era prodiga, generosa di natura, incapace di provare avversione e rancore, neppure nei confronti delle sorelle Sbrilli.
-Mi pare che mi guardino con disprezzo – confidò al marito, prima della disgrazia – forse dipende dal fatto che siamo meridionali …
Poi accadde che la signorina Egle morì, non si capì bene di cosa perché la donna non usciva mai di casa e non parlava con nessuno. La badante, una garbata donna russa, se ne era andata via qualchemese prima e Rosa si era chiesta spesso come facesse l’altra signorina anziana e sola a tirare avanti. Un giorno aveva bussato alla porta chiedendole se poteva aiutarla, ma aveva ricevuto dinieghi assoluti.
-Non ci badare Rosa – fu il commento del maresciallo – secondo me, non ci sta più con la testa!
Ed era vero: quelli della Neuro se l’erano venuti a prendere e per un certo periodo nel caseggiato non si parlò d’altro. Poi, come tutte le cose, anche questa passò e delle sorelle Sbrilli non rimase traccia. Vennero degli uomini di un’impresa sgombra soffitte che si portarono via tutto, compreso un ammasso di sporcizia e ragnatele. Pochi mesi dopo l’appartamento fu occupato da una famiglia di extracomunitari africani e così si venne a sapere che le Sbrilli avevano lasciato la casa in eredità alla parrocchia. Qualcuno bofonchiò con malumore, altri trovarono da dire sul fatto che c’erano dei bambini, la signora dei gatti al primo piano non se ne accorse nemmeno. Rosa si precipitò a dar loro il benvenuto con un piatto di calongelli fritti, visto che si era alle porte di Natale. Non pensò che forse gli inquilini non avrebbero festeggiato il Natale dal momento che erano di fede musulmana, le sembrò naturale accoglierli con il gesto di cortesia che è di casa in tutto il mondo. Le apparvero gli occhi stupiti di tre bambini, le loro mani protese verso il piatto dei biscotti. La madre si esprimeva in un italiano approssimativo, ma le sembrò di capire che fossero parole di ringraziamento. Era una giovane donna, alta e flessuosa, avvolta in una tunica dai colori sgargianti, forse dell’età della terzogenita dei Muttone.
-Si chiama Amina. Naturalmente lei è nera – disse al marito – ma gli occhi mi ricordano quelli di Giulia: sono due carboni ardenti!
-La tua solita mania delle somiglianze – sospirò il maresciallo – ogni persona ti ricorda qualcun altro. Non lo sai che a questo mondo siamo tutti diversi?
-Diversi sì, ma nello stesso tempo uguali – rispose Rosa inalberando l’aria testarda che il maresciallo bollava con:
-Sei ciucciuta come un mulo!
Remissiva e paziente Rosa s’incaponiva davanti a quelle che considerava delle ingiustizie. Le era naturale schierarsi dalla parte dei più deboli ed indifesi. Fin da bambina quando vedeva che qualcuno maltrattava il prossimo, umano, animale o vegetale, si accalorava in sua difesa. Da quella paciosa bambina che era, si trasformava mutando i lineamenti del viso, alterando la voce e i gesti. E non bastava. Riempì di randagi la casa paterna e quando le fu vietato, ricorse alle case dei nonni, degli zii e prozii che aveva in gran quantità. A scuola aiutava le più testone, quelle che la maestra confinava negli ultimi banchi. Spesso erano bambine più povere di lei, senza scarpe e con le croste al naso. Si guadagnò il nomignolo di suor Rosa, lei che con le monache aveva conti in sospeso da quella volta che osò criticare la Superiora e le consorelle che premiavano con le medagliette di buona condotta le bambine più volonterose e pie. Guarda caso, erano le figlie dei maggiorenti del paese. La povera Angelina, figlia di uno stagnino, si spaccava la schiena a lucidare pavimento, statue e banchi della chiesa, a strofinare candelieri ed inginocchiatoi, ad infiorare l’altare con mazzi di ginestra raccolta nei campi di buona mattina; per lei niente, nemmeno una carezza sui capelli di stoppa gialla o un sorriso che l’avrebbe ripagata di tanta fatica. Alla primogenita Rosa diede il nome di Angelina e fu irremovibile quando il maresciallo le chiese di cambiarlo a favore di quello della madre, anima santa volata in cielo. Così come fu decisa nel prendere le difese dei figli ogni qualvolta avvertisse pericolo o ingiustizia. Perorò la causa di Donato che il padre voleva gendarme come Cosimo ed invece scelse di diventare veterinario. In lui Rosa ritrovava l’amore per gli animali e la natura. Si fece complice delle figlie alle prese con il primo batticuore, nascose le pagelle di Nicola, lo scavezzacollo di famiglia, quello che più di tutti diede preoccupazioni e noie per le sue idee di giustizia e libertà. Non si tirò indietro nel difendere la famiglia degli extracomunitari dagli attacchi e dalle invettive di coloro che, nel caseggiato, cominciarono a mugugnare. Ed erano solamente i vecchi. Con la signorina Ghitta, sua dirimpettaia, intavolò una discussione a proposito del fatto che Amina, quando usciva, portasse il velo. A lei piaceva lo strano affascinante modo di vestire, sgargiante di viola, azzurro, arancione, rosa, castigato dal turbante nero che avvolgeva i capelli. Alla signorina Ghitta dava fastidio. Prese le difese della ragazzina di dieci anni che, una mattina, osò cogliere da uno dei vasi, sistemati in androne, un fiore di clivia da portare alla sua maestra. Quel gesto scatenò il putiferio.
Alla prossima settimana.