La Sirenetta

Nella mitologia arcana, le storie sulle sirene sono sempre state associate a scenari tetri e distruttivi: relitti fantasma, velieri distrutti, oceani in tempesta, flutti che s’infrangono con violenza sugli scogli, cadaveri di marinai che galleggiano su assi di legno trasportati chissà dove dalle correnti dei mari, abissi e mostri marini: oceani e mari sottomessi in eterno al volere del loro re, Poseidone.
E poi loro: strani esseri dalla cui voce nasceva un canto soave ed ammaliante, capace di stregare chiunque lo ascoltasse.
Le sirene erano descritte come delle creature marine estremamente sensuali: il loro corpo rappresentava una irresistibile seduzione per i marinai, che nella solitudine dei viaggi, cedevano facilmente alla follia del loro richiamo. Accecati nei pensieri, gli uomini trovavano la morte tra le braccia delle sirene, conducendo le proprie navi alla rovina.
Bellissime nel volto quanto sinistre e diaboliche nella mente, le sirene venivano descritte come degli ibridi ittiomorfi: straordinariamente femminili nelle loro sembianze ma soltanto fino al busto. Dalla vita in giù erano invece dotate di una sorta di coda pinnata la quale consentiva loro di nuotare liberamente in mare aperto, con estrema naturalezza e leggiadria.
Avevano lunghissimi capelli per coprire le nudità del seno e monili dorati dalle sembianze di serpi o di lunghi tentacoli ad ornare le braccia ed il collo (preziosi trafugati, con ogni probabilità, dai relitti poi andati perduti negli abissi).
Nel solcare le acque, le loro code strofinavano sul fondo del mare, catturando perle preziose che aderivano alle loro squame senza più staccarsi, fornendo a ciascuna di loro una lucente pelle riflettente. Nonostante l’ambiente naturale nel quale muoversi perfettamente fossero il mare e le onde, le sirene riuscivano ed adagiarsi anche sulle rive, traendo conforto e piacere nello sdraiarsi sugli scogli, venendo accarezzate dagli schizzi dei flutti che poi, infrangendosi contro le rocce, ne bagnavano i corpi.
Quando avvistavano una nave all’orizzonte cominciavano a far echeggiare il loro dolcissimo canto ed una volta che i marinai soggiogati indirizzavano le vele verso la loro isola, le sirene si immergevano in acqua nuotando verso la prua della nave destinata. Lasciavano i loro corpi semi sommersi, mostrando solo il tronco nudo, generando così un turbinio di passione a tutti coloro che le osservavano attoniti ed al contempo ammaliati.
Nelle mente di quegli uomini i melodiosi canti ricordavano quanto di più tenero e allettante i loro pensieri potessero mai rammentare: il sorriso di una madre perduta, la risata di una fanciulla un tempo amata oppure quello di una giovane sposa ormai lontana che probabilmente invocava nelle sue preghiere il ritorno del proprio marito ogni notte. Incapaci di resistere oltre, i marinai si gettavano in mare, alla disperata ricerca di quelle creature tanto incantevoli e belle, per nulla coscienti che in quegli istanti la loro fine sarebbe giunta implacabile dal fondo del mare: mani misteriose avrebbero di lì a poco afferrato le gambe degli stolti per trascinarli a fondo, negli abissi più cupi, dove era pronta ad attenderli la morte. Poi, una volta raccolti i corpi ormai privi di vita, le Sirene si sistemavano nuovamente sulla riva riempiendo in coro l’aria con l’eco di una nenia malinconica che ne sentenziava il congedo, come in un mistico

Quella che vi ho appena raccontato è la descrizione più classica del mito delle sirene o perlomeno la loro rievocazione descrittiva ritenuta più valida fino all’anno 1837, vale a dire fino a quando il genio letterario di Hans Christian Andersen rese partecipi i propri lettori di un capolavoro destinato a mutare per sempre ciò che si poteva immaginare sulle sirene.
Le sirene con Andersen non furono più soltanto creature sensuali, bellissime quanto mortali ma divennero donne sognanti e innamorate, creature dall’animo puro e incontaminato, anime cristalline, capaci di amare incondizionatamente un uomo. Insomma, con la fiaba dell’autore danese, le sirene vennero universalmente riconosciute anche come delle essenze femminili di armoniosa e infinita grazia.
Creatore di fiabe che sono ormai patrimonio mondiale della letteratura, Hans Christian Andersen deve la sua fama alla sapienza con cui è riuscito a coniugare la semplicità e la profonda verità della tradizione popolare con la sua poetica fantasia venata di bonaria ironia quanto di malinconica dolcezza.
Hans Christian nacque a Odense il 2 aprile 1805 e morì a Copenaghen il 4 agosto 1875. Il padre era un calzolaio, estremamente povero che non amava molto il suo lavoro: uomo originale e pifferaio per vocazione, sembrava felice solo quando guidava il piccolo Hans nell’esplorazione delle sue poche ma ricche letture (fra cui Le mille e una notte). La madre, invece, non aveva ricevuto alcuna istruzione, ma trasmise al figlio l’intenso patrimonio di fiabe e leggende popolari, che mescolandosi alle letture paterne contribuirono a stimolare ed arricchire l’immaginazione di un bambino da sempre molto sensibile, forse anche perché emarginato sia socialmente che fisicamente.
Fu scrittore e anche un poeta ma la sua celebrità la ottenne per merito delle splendide fiabe che seppe immaginare: da La piccola fiammiferaia a Il brutto anatroccolo, Il soldatino di stagno, Il vestito nuovo dell’imperatore, fino ad arrivare alla più nota, La Sirenetta che venne pubblicata il 7 aprile dell’ anno 1837.

Protagonista della fiaba era, come dice il titolo stesso, una Sirena, o meglio, una sirenetta, tanto gentile, tanto bella, ma anche tanto sfortunata. La sua storia ha qualcosa che non si trova di solito nelle altre fiabe: non mette solo in moto la nostra fantasia, la nostra immaginazione, mette in moto soprattutto il nostro sentimento.
Una storia irreale per le vicende narrate ma reale per l’umanità dei personaggi e per i caratteri così vivi, così autentici, così veri con cui Andersen seppe descriverli .
La favola narra la triste vicenda della giovane sirena che salva un principe caduto in mare durante una tempesta. Ella se ne innamora perdutamente e desidera addirittura lasciare il mare per tornare a vivere sulla terra. Per ritrovare il suo principe, dona la sua voce in cambio di un paio di gambe: ha tre giorni di tempo per ricevere il bacio d’amore da colui che la trasformerà in un essere umano ma, se non lo otterrà, si trasformerà in schiuma marina. Una volta ritrovato, il principe rimane attratto da lei ma non la riconosce: ricorda solo di essere stato salvato da una ragazza dalla voce magica e quindi, sposa un’altra donna. Con il cuore infranto, la Sirenetta si lancia da una scogliera e si trasforma in schiuma marina.
Il nostro cuore soffre e si rattrista per la sirena così dolce e delicata, così pronta al sacrificio: ad un sacrificio che le costa la rinuncia al canto e alla parola e la costringe ad una continua sofferenza fisica. Ella cerca la felicità nel mondo degli uomini e, quando si accorge che non può realizzare il suo sogno d’amore, diventa una magnanima dispensatrice di bene e d’affetto per colui che, senza saperlo, l’ha fatta tanto soffrire.
La Sirenetta per il suo modo di sentire, è veramente una creatura umana, appunto per questo Andersen ha immaginato per lei, come premio, come ricompensa finale, un’anima immortale.
Con la sua protagonista l’autore vuole puntare alla ricerca delle emozioni e dei sentimenti. Per questo crea una figura malinconica e sensibile, altruista e decisa, che nel corso della narrazione vediamo addirittura crescere e maturare. Una volta diventata persona umana la sua vita sarà solamente un alternarsi di speranze e di delusioni.
A differenza delle altre fiabe, che di solito si concludono con la famosa formula … «E vissero tutti felici e contenti» ne La Sirenetta siamo in presenza di un finale triste, sconvolgente, anche se intriso di profonda morale.
In effetti essa è solo apparentemente una fiaba: Andersen usò alcuni elementi del fiabesco come appiglio per narrare un’affascinante, quanto malinconica storia d’amore, un isolamento amoroso che fu lo stesso che egli provò in vita per via della sua taciuta omosessualità.
Ecco perche Andersen impresse il proprio dolore su quei fogli di carta, la sua vivida sofferenza emotiva in quelle stesse parole che narravano il triste destino de La Sirenetta, costretta a rimanere muta come quel senso di profonda insoddisfazione che egli stesso patì, nel dover tacere la sua diversità.

Molti anni dopo, nel 1989, anche il colosso Disney credette nella magia di questa favola e la mise in produzione. In breve, fu pronto a distribuire nei cinema di tutto il mondo La Sirenetta, il primo classico del cosiddetto Rinascimento Disney. Il lungometraggio d’animazione, seppure ispirato alla fiaba, ritenne necessario mutare alcuni punti chiave della storia, donando alla protagonista (battezzata nel film con il nome di Ariel, che richiama lo spirito dell’aria di William Shakespeare), un lieto fine.
Su questo permettetemi di scrivere, a caratteri cubitali il mio commento, vale a dire: fortunatamente(!)
Si perché, sebbene la storia di Andersen sia assolutamente perfetta – un vero elogio alla sua fantasia creativa in grado di far riflettere sulla tragicità di una fiaba che mescola interpretazioni velate con la realtà – il finale dell’opera è incredibilmente straziante.
Un film che riadattasse il racconto restituendo a La Sirenetta un atto conclusivo sereno e felice fu un vero e proprio dono che la Disney offrì non soltanto alla sua protagonista ma a tutti i fan (come la sottoscritta) che amavano la fiaba originale e che, pur rispettando il volere dell’autore, provavano un senso di profonda angoscia, rammentandone il dramma finale che invece, grazie al lungometraggio Disney, ha potuto essere analizzato da una prospettiva tutta nuova.
Il cartone animato de La Sirenetta fu un capolavoro che trattò splendidamente il tema del diverso e l’incontro tra due mondi attraverso un amore corrisposto dal valore ineluttabile, un classico di raffinata pregevolezza: la restituzione scenica di tutto quel mondo sottomarino fu a dir poco magnifica, al punto tale da riuscire a fare letteralmente immergere gli spettatori nei propri fondali.
Il film ebbe il merito di conferire nuova e preziosa linfa vitale anche alla Walt Disney Production, che di fatto era reduce da un periodo di scadenti risultati di critica e di pubblico. Il film diretto da John Musker e Ron Clements fece da apripista al periodo di successi sfolgoranti che dureranno per tutti gli anni ’90: la storia di Ariel ebbe anche il grande merito di aver ripristinato le parti musicali come elementi essenziali e peculiari dei migliori classici Disney. Grazie alle proprie musiche il film vinse infatti due premi Oscar, per la migliore colonna sonora e la migliore canzone ( cosa che si ripeterà più volte per le successive opere della Disney, la quale da questo momento in poi impiegherà sempre ampi sforzi per garantire una resa di altissimo livello nelle parti musicali).

Se per la versione animata la Disney Production optò per il lieto fine, invece il triste epilogo della storia d’amore è stato da sempre magistralmente e identicamente rappresentato nell’omonimo balletto di Hans Beck, musicato da Fini Henriques. Lo spettacolo di Beck, messo in scena per la prima volta ai primi del secolo, affascinò a tal punto il mecenate della birra danese Carl Jacobsen(fondatore della Carlsberg-Tuborg) che, nel 1909, commissionò allo scultore Edward Eriksen la realizzazione di una statua la quale avesse come protagonista lei, la Sirenetta : egli volle inoltre che la delicata scultura, una volta realizzata, venisse posta su uno grosso scoglio granitico nel quartiere dell’antico porto di Nyhavnall , all’ingresso del porto di Copenaghen.
Jacobsen desiderava che la prima ballerina danese Ellen Price facesse da modella per la scultura, ma questa si rifiutò di posare nuda. Infine, il corpo della sirena fu pertanto ispirato alla moglie di Eriksen e la Price posò soltanto per la realizzazione del viso. La scultura, alta 1,25 metri, fu inaugurata nell’agosto del 1913, sulla scia della moda di decorare i parchi e le strade di Copenhagen con sculture di personaggi classici e storici.
Da allora la statua della Sirenetta è divenuta il simbolo indiscusso della città.
Ad oggi, quella che i visitatori di tutto il mondo ammirano sullo scoglio nel porto è solamente una copia, ciò che ci toglie un po’ di quella sua straordinaria magia. L’originale viene conservato dagli eredi di Eriksen in un luogo segreto.
Vi è un’ottima ragione per tutto questo: negli anni passati la Sirenetta fu danneggiata diverse volte, divenendo la triste protagonista di parecchie disavventure.

La piccola creatura bronzea è stata infatti tristemente decapitata per ben due volte; è stata anche dipinta di rosso e poi di rosa, poi le è stato tagliato un braccio ed è stata pure gettata in mare. E’ stata anche utilizzata come manifesto di propaganda o di protesta contro il nucleare e contro l’ingresso della Turchia in Europa (facendole indossare un burqa).
Recentemente è divenuta anche il simbolo della lotta degli animalisti contro la terribile strage mondiale delle balene.
È comunque evidente quanto ormai l’essere diabolico e tentatore che aveva tentato di interrompere nella morte il viaggio di Ulisse e dei suoi marinari, nel tempo si sia trasformata nel simbolo dell’amore puro e del coraggio. Un grande mito rinobiliato grazie ad Andersen ed alla sua splendida fiaba.
Ecco perché il racconto de La Sirenetta, resta comunque un capolavoro assoluto da raccontare a tutti i bambini del mondo, prima di addormentarsi… proprio come fu raccontata a me.
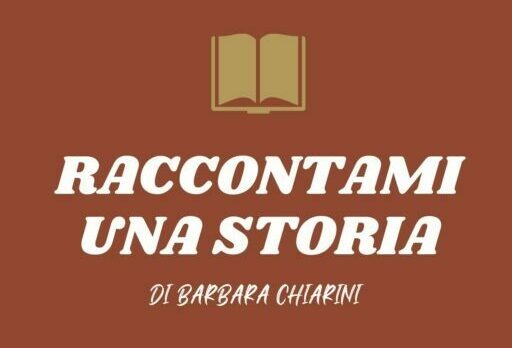


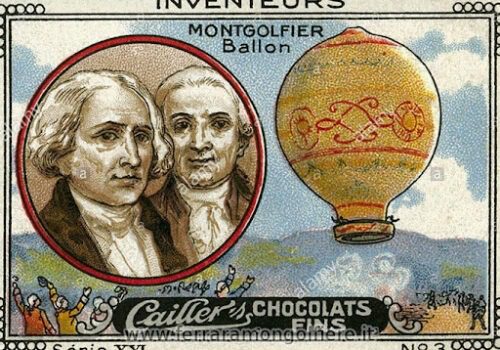

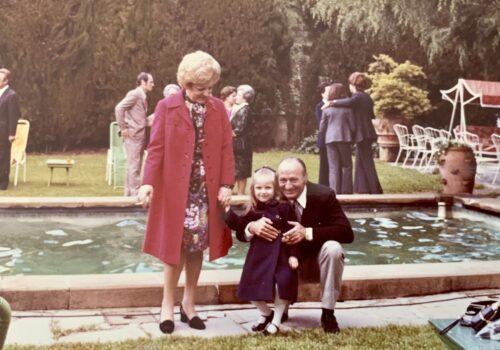
Bellissima narrazione anche se trattasi di una fiaba assai triste che però ci lascia pensare su cosa possa essere l’Amore con la A maiuscola. Complimenti per la narrazione